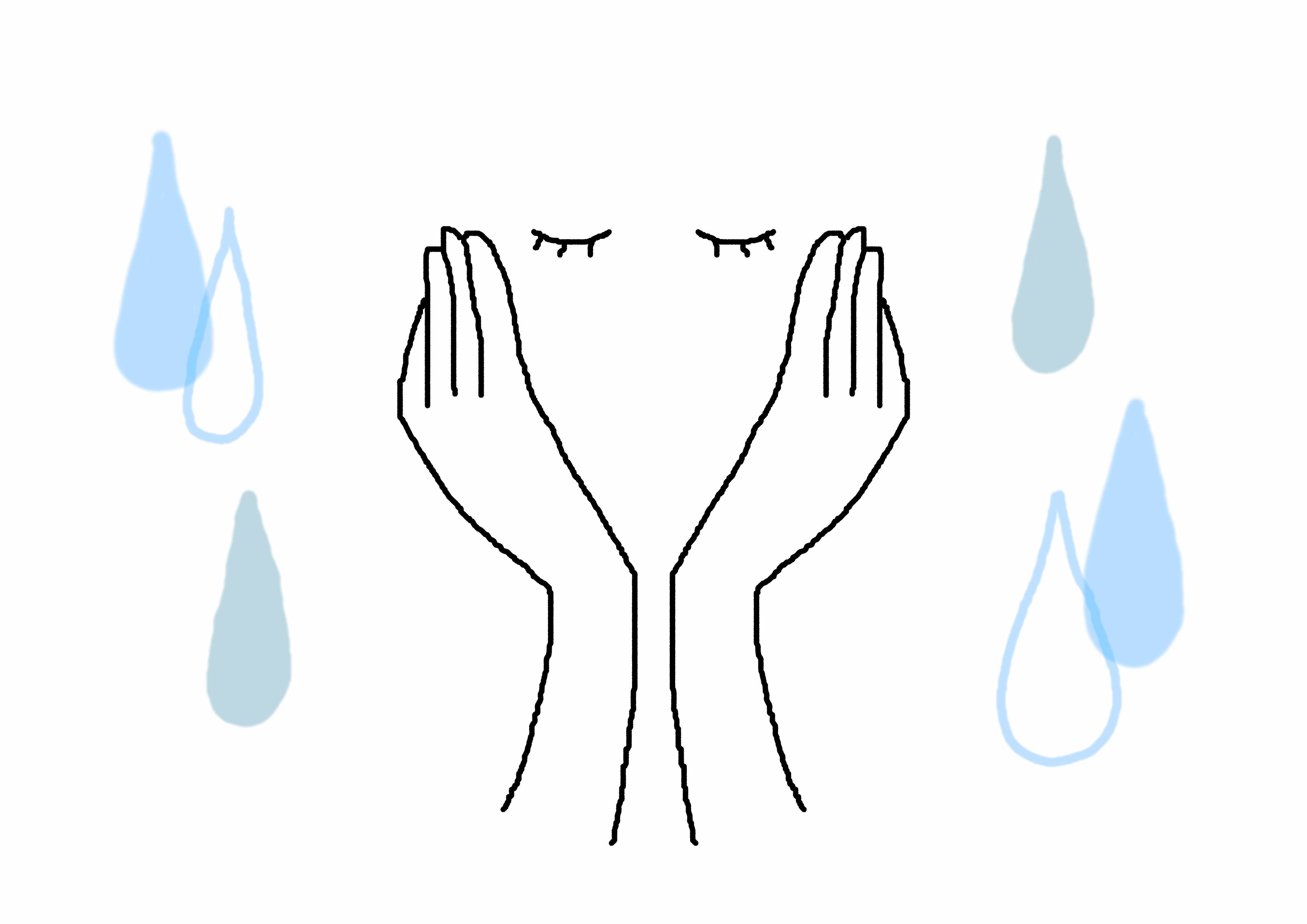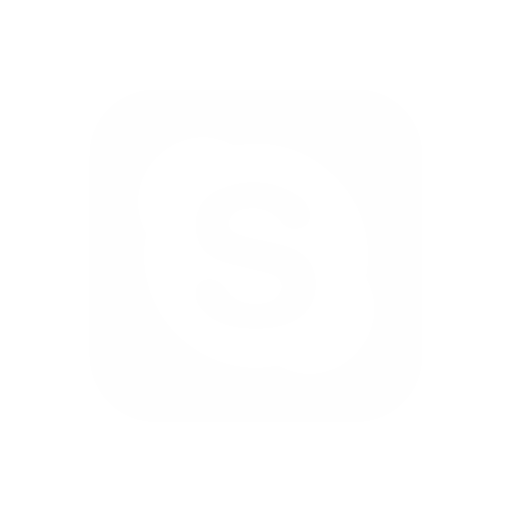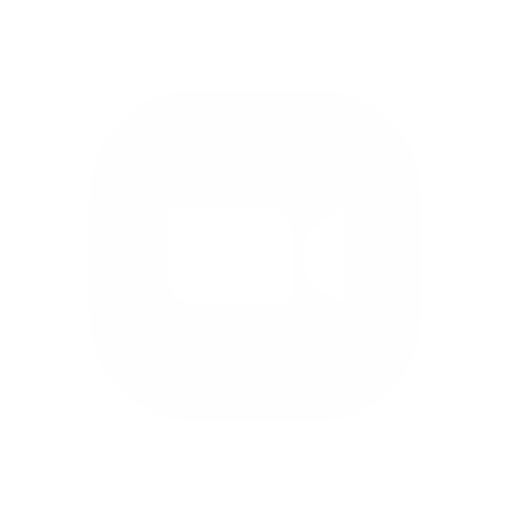Tra le emozioni più dolorose che un individuo possa sperimentare, la vergogna occupa spesso un posto di rilievo.
La vergogna si manifesta quando si è criticati o si riceve meno approvazione del previsto, quando si teme di non essere all'altezza delle aspettative proprie o degli altri, quando si teme di non far fronte alle richieste quotidiane, o quando si teme di aver "perso la faccia". A volte, la vergogna può essere così pervasiva e paralizzante da minacciare l'integrità del Sé.
In termini psicoanalitici, sembra che l'individuo si confronti costantemente con un pubblico immaginario critico e eccessivamente severo. Tuttavia, non si tratta del tradizionale conflitto tra l'Io e il Super-Io legato alla colpa. Nella vergogna, il conflitto si basa sul confronto tra un Io reale e un Io ideale, non orientato verso un ideale futuro che ci spinge a progredire e migliorare. Come descritto in Giovani adulti: di cosa hanno paura, si tratta piuttosto di un Io ideale attuale che prescrive come dovremmo essere ora, spesso con aspettative distanti dalla realtà (Laplanche J., Pontalis J. B, 1993).
Questa situazione può portare a percepirsi come "intrinsecamente imperfetti", una caratteristica comune ma sottile del narcisismo, noto come "narcisismo vulnerabile e ipervigile". Le persone che soffrono dI questo tipo di narcisismo sono estremamente sensibili alle reazioni e ai giudizi altrui (Glen Gabbard, 2015).
La vergogna è un'emozione sociale autoconsapevole negativa e universale che coinvolge il nostro rapporto con gli altri e con noi stessi nelle relazioni. Quando proviamo vergogna, desideriamo sparire, allontanarci. Questo sentimento è strettamente legato all'autostima, portandoci a sentirci privi di valore, inadeguati e impotenti. Al contrario, possiamo anche provare risentimento, collera, rabbia e il desiderio di rivalsa, spesso in modo inconscio.
Colpa e vergogna talvolta si sovrappongono, ma non sono la stessa cosa
Entrambe sono emozioni autoconsapevoli negative, ma presentano differenze significative. Nella colpa si è consapevoli di aver arrecato danno, materiale o emotivo, a qualcuno, rimane circoscritta all'azione o al fatto stesso, con confini precisi e identificabili. Al contrario, la vergogna è autoreferenziale e coinvolge la persona nella sua totalità. La vergogna patologica comporta spesso un dolore mentale e una tristezza invalidanti.
Nella colpa si sperimenta ansia, rimorso per aver agito o omesso qualcosa, e dispiacere per aver causato danno. A differenza della vergogna, in cui si desidera fuggire o vendicarsi per l'umiliazione subita, nella colpa si cerca di rimediare al torto inflitto, con un desiderio di cambiamento e di riconciliazione anziché di fuga. Per questo motivo, elaborare la colpa è di solito meno problematico rispetto alla vergogna.
Nella vergogna l'attenzione è sul Sé (sono sbagliato) e su come gli altri ci giudicano, mentre nella colpa ci si concentra sulle conseguenze delle proprie azioni sugli altri, coinvolgendo l'empatia e il punto di vista dell'altro (ho sbagliato ma posso rimediare). Attraverso il riconoscimento della responsabilità, si cerca di ricostruire la relazione danneggiata. Pur presentando aspetti relazionali e cognitivi diversi, vergogna e colpa si influenzano reciprocamente e coesistono spesso. Tuttavia, chi tende più alla vergogna può manifestare ostilità e rabbia verso gli altri, nota come "furia da umiliazione". Nonostante la colpa sia meno dolorosa della vergogna, richiede tempi più lunghi per essere risolta (Anolli, 2010).
Come gestire le emozioni legate alla colpa
Il processo di gestione della colpa può essere un'opportunità per crescere e migliorare se stessi. Accettare la propria responsabilità e cercare di riparare al danno causato sono passi fondamentali per smussare gli effetti negativi della colpa e per favorire la crescita personale. È importante ricordare che tutti commettono errori e che è umano provare sentimenti di colpa.
Accettare i propri errori e impegnarsi per riparare il danno causato sono segni di maturità e resilienza. É normale provare sensi di colpa, ma ciò che conta davvero è come si reagisce a questa emozione. Coltivare la compassione verso se stessi e gli altri è fondamentale per superare la colpa in modo sano e costruttivo.
Infine, imparare a riconoscere le emozioni di vergogna e colpa, sebbene la prima sia più dolorosa della seconda, e sebbene abbiano funzioni e radici diverse, rappresenta un passo fondamentale per comprendere meglio le proprie dinamiche emotive e affettive e migliorare le relazioni interpersonali.
Quando queste emozioni sono ricorrenti, pervasive e invalidanti, può essere utile intraprendere un percorso di sostegno psicologico o psicoterapeutico finalizzato alla rielaborazione del vissuto emotivo e alla promozione di un benessere psicofisico complessivo.
Fonti:
- L. Anolli, La vergogna, quando la nostra immagine va in frantumi e vorremmo sprofondare, Il Mulino, 2010.
- G. Gabbard, Psichiatria Psicodinamica, Raffaello Cortina, 2015.
- Laplanche J., Pontalis J. B., Enciclopedia della psicoanalisi, Laterza, 1993.
Sitografia:
- Bernadette O’Sullivan, Comprendere la colpa, approfondire la vergogna. Rivista Italiana di Costruttivismo, https://www.rivistacostruttivismo.it/30/04/2015/articoli/bernadetteosullivan/comprendere-la-colpa-approfondire-la-vergogna/
- Hyeman Choi,Integrating Guilt and Shame into the Self-Concept: The Influence of Future Opportunities, https://www.mdpi.com/2076-328X/14/6/472/
- Bruce Wilson Ph.D., About Distorted Guilt and Shame, Guilt arises when we think that we have done damage to something or someone, https://www.psychologytoday.com/us/blog/explorations-in-positive-psychology/202411/distorted-guilt-and-shame/
- Pivetti, M., Camodeca, M. & Rapino, M. Shame, Guilt, and Anger: Their Cognitive, Physiological, and Behavioral Correlates. Curr Psychol 35, 690–699 (2016). https://doi.org/10.1007/s12144-015-9339-5
Immagine: Adobe Stock